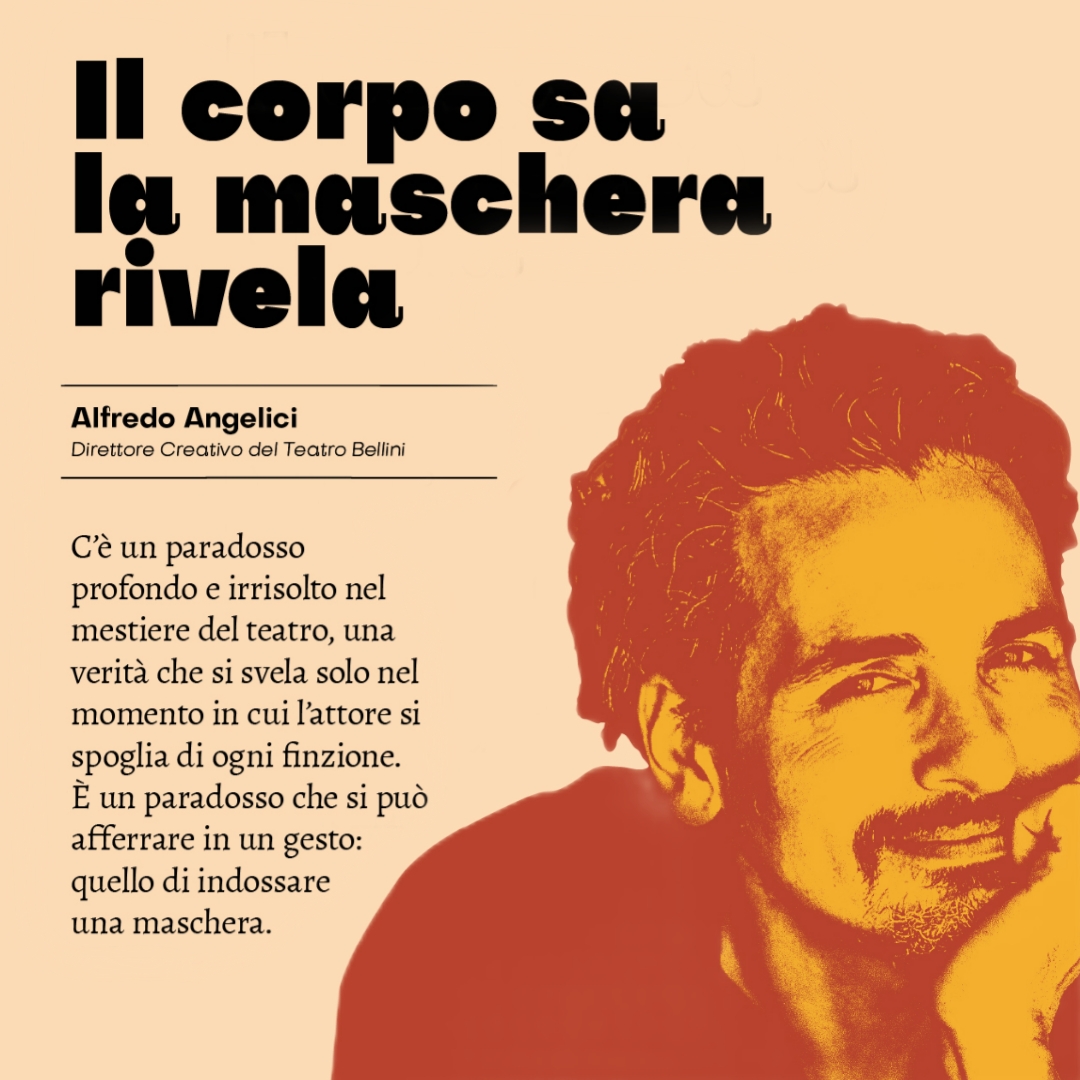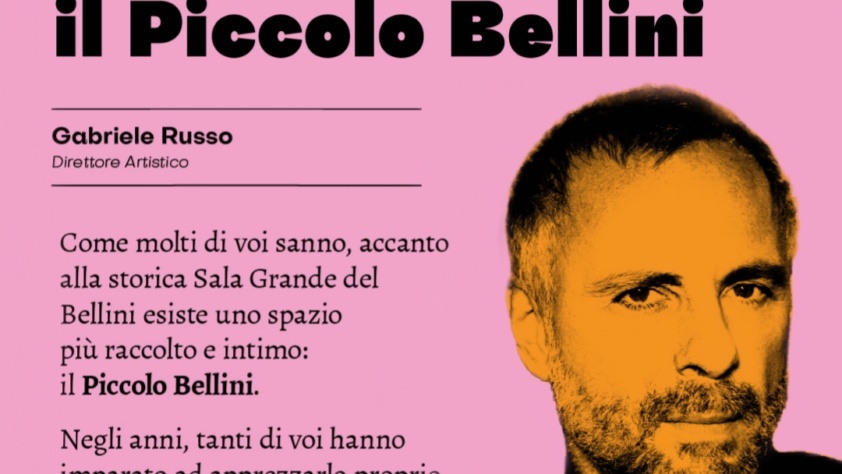di Alfredo Angelici
Direttore Creativo del Teatro Bellini
The Belliner n.45
A: Chi sei?
B: Chi… chi è soltanto la forma conseguente alla funzione, ma ciò che sono è un uomo in maschera.
A: Ah, questo lo vedo!
B: Certo, non metto in dubbio le tue capacità di osservazione. Sto semplicemente sottolineando il paradosso costituito dal chiedere a un uomo mascherato chi egli sia.
(A. Moore)
C’è un paradosso profondo e irrisolto nel mestiere del teatro, una verità che si svela solo nel momento in cui l’attore si spoglia di ogni finzione. È un paradosso che si può afferrare in un gesto: quello di indossare una maschera. In un mondo ossessionato dal volto, dall’identità anagrafica, dalla rassicurazione della riconoscibilità, la maschera ci invita a un viaggio a ritroso. Non è un travestimento, né un artificio che nasconde, ma, al contrario, un dispositivo che rivela. Nel momento in cui l’attore la indossa, il volto quotidiano, con i suoi tratti e le sue abitudini, viene messo da parte per lasciare emergere un’energia più profonda e universale. La maschera diventa allora uno specchio di verità essenziali, un passaggio verso una condizione originaria che l’attore può incarnare solo liberandosi da ciò che gli appartiene in maniera troppo personale.
Per anni ho inseguito le maschere e i loro maestri: le neutre, le larvali, quelle della commedia, le espressive e le deformazioni del grottesco, fino alla maschera più piccola del mondo: il naso rosso. Ho sudato, ho riso e ho fallito. Ho capito che la maschera, quando è una ricerca autentica, non ti lascia mai davvero. Continua a seguirti, a parlare attraverso il tuo corpo, a sollecitare il gesto e il respiro. Sono maestre silenziose, arbitre esigenti, compagne di gioco e di fatica.
Voglio condividere con te questo viaggio che feci, un viaggio che affonda le sue radici nei rituali collettivi più antichi, in cui il quotidiano perde valore. Le maschere sono un grido di libertà: nell’anonimato si azzerano le gerarchie e tutto diventa possibile. Un po’ come ritrovarsi in una qualsiasi notte di mezza estate, dove servi e padroni si mescolano e il desiderio può diventare pericoloso e prendere il sopravvento.
La mia investigazione è partita dalla maschera neutra, in Francia. La neutra è il fondamento di ogni ricerca: annulla il volto per restituire al corpo la sua essenza. Portarla significa spogliarsi dei gesti ripetitivi e delle psicologie individuali. Ti trovi costretto a ritrovare, o perlomeno a cercare, un corpo sincero e disponibile al gioco scenico. In questo caso non porti in volto il segno di un personaggio, ma un terreno vergine su cui costruire: lo stato primigenio in cui tutto è ancora possibile. Mi viene in mente il mio gatto, quando è immobile ma pronto al balzo: nella sua immobilità si legge già tutta la potenza del salto che sta per avvenire. In questo spazio di tensione neutra, in questa assenza senza volto, essere presenti significa ascoltare il corpo, perché — come ripeteva spesso Lecoq — “il corpo sa cose che la testa non conosce ancora”.
Facendo un balzo spazio-temporale, decisi poi di andare a Basilea alla ricerca dei Larven, i mascheroni abnormi e senza forma che rivivono ogni anno durante il carnevale. Erano le quattro del mattino quando, durante il rito del Morgestraich, ho letteralmente sbattuto contro uno di questi mascheroni larvali: enormi, deformi e caricaturali, muti. Che incredibile privilegio è stato per me restare lì, pieno di stupore, davanti a questi esseri sospesi che sembravano provenire da un altro mondo. Immaginare le loro provenienze e le storie fantastiche che suggerivano.
Queste maschere sono state poi “rubate” alla tradizione e portate dai teatranti nelle sale prova per via della loro espressione non fissa, larvale appunto, che si modella e cambia in base al movimento — grande, lento e deciso — e alla respirazione di chi le indossa. Lavorare con loro è un’iniezione di dopamina per la fantasia e uno stimolo alla creatività, una doccia fredda che smorza l’ego dell’attore. Non c’è spazio per l’identità personale, se l’immediatezza della metafora prende vita sul palco.
Nel lavoro d’attore con la maschera si consuma un percorso obbligato, non facile: un rito di transizione, il caos temporaneo che precede il ritorno all’ordine. Gioco, provocazione, catarsi.
Dopo questo caos primigenio della maschera larvale, feci tappa a Venezia per incontrare “i comici” che codificarono l’umano in archetipi riconoscibili. Le mezze maschere della Commedia non nascondono, ma rivelano con ferocia gli “abiti del demonio”: ovvero i vizi, che più delle virtù raccontano chi è l’uomo, insieme alle sue tipologie. Portando in scena i personaggi, interpretiamo la maschera sociale che indossiamo per vivere in società. Le mezze maschere della Commedia venivano passate da attori anziani a più giovani e con esse l’attore riceveva in eredità un tacito manuale di istruzioni: come l’archetipo scolpito su quella maschera si muove, parla, sogna, desidera. Soldi, cibo, sesso, potere, vanagloria, boria.
La tensione tra identità e maschera si è catastroficamente materializzata, in modo esemplare, quando ho incontrato la relazione pericolosa tra il clown e il buffone: due estremi della stessa deformazione. Il naso rosso, con la sua ingenuità, ci mette davanti alle nostre miserie, al nostro meraviglioso stupido stupore. È vulnerabile, puro, pronto a fallire e a trasformare il fallimento in gioia condivisa. “Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono.” Il clown si offre in sacrificio: la sua maschera è un volto aperto, un’onestà che si trasforma in risata. Philippe, il mio maestro, ricordava spesso: “dans chaque chute, chaque hésitation, chaque regard naïf, il nous apprend à voir l’invisible et à toucher l’essentiel”. Ma io non parlavo francese.
Diversa è la maschera del buffone, che non è una maschera in volto, ma una maschera indossata da tutto il corpo, trasformato e deformato. Lui non ha più nulla da perdere. Cacciato dalle corti dei re, reietto perché con quella sua deformità, fisica o psicologica, non poteva essere figlio di Dio, la sua rivincita è la parodia cattiva e irriverente, lo sberleffo nei confronti del potere. La sua maschera non cerca l’empatia, ma la provocazione feroce, la verità spietata. Il buffone incarna una potenza trasgressiva e grottesca, che usa la sua stessa deformità per smascherare l’ipocrisia del mondo. È la rabbia dell’escluso, trasformata in arte.
In questo solco di ricerca, che ho condiviso solo superficialmente, si inserisce un gruppo come la Familie Flöz, che ha portato a Napoli, nel nostro teatro, la sua arte di maschere espressive che prendono vita — eccome se prendono vita! Sono artisti che testimoniano come una maschera possa diventare uno strumento di profonda umanità. I loro volti di cartapesta non si muovono, ma il corpo degli attori, con un’espressività millimetrica e un ritmo impeccabile, li anima, li fa ridere, piangere e amare. In loro si vede l’essenza della maschera: non è l’oggetto a parlare, ma l’attore che si mette a sua disposizione, che lo fa vibrare, che lo carica di un’emozione che non ha bisogno di parole per essere compresa.
In definitiva, la maschera non è un passaggio tecnico, ma una vera educazione all’essenziale. Non è il segno di un personaggio, ma lo stato primigenio in cui tutto è ancora possibile: un terreno vergine su cui costruire una PERSONA.